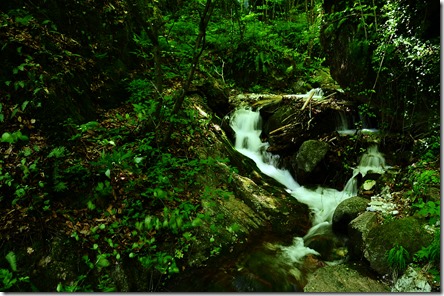Ieri, 23 aprile, era la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d'autore. Talmente indaffarata (e raffreddata, pure) da non trovare nemmeno il tempo di andare a ritirare il mio libro in regalo in biblioteca!
Però domani è il 25 aprile, così ne approfitto per parlare di un libro resistente:

Giovanna Zangrandi
I Giorni veri
Diario della Resistenza
Editore:
Isbn Edizioni
Anno 2012
pagine 288, brossura
ISBN: 9788876383359
disponibile anche in e-book: mobi e epub
Lo scoppio della seconda guerra mondiale trova Giovanna Zangrandi, pseudonimo di Alma Bevilacqua, in Cadore dove insegna scienze naturali nelle scuole di Cortina e di Pieve di Cadore, va per monti e diventa maestra di sci e dove continua a leggere, studiare e scrivere articoli e racconti, pubblicati con frequenza su riviste locali. Il generico antifascismo che la caratterizza nei primi anni di guerra si va delineando con l’8 settembre: sceglie infatti di entrare nella resistenza nella brigata garibaldina Pier Fortunato Calvi, Divisione Nannetti.
La possibilità di attraversare quasi quotidianamente la frontiera con il Reich (la montagna del Cadore e in particolare Pieve era stato annesso all’Alpenvorland) e la sua profonda conoscenza del territorio e delle montagne le permettono di portare ordini e armi alle varie brigate disseminate sul territorio e di individuare dove e come piazzare le mine e sabotare i nazisti. Camminate stremanti fra i monti, ore e ore sugli sci fra le montagne più belle del mondo che hanno già visto la guerra e la morte.

Civetta
Ovviamente alla lunga iniziano i sospetti, e probabilmente qualcuno si prende la briga di denunciarla: fatto sta che la compagna Anna entra in clandestinità e sale in montagna. Da sola: la banda partigiana non prevede donne.
Riprende i contatti con i partigiani e a muoversi sul territorio fino al novembre ‘44 e al proclama di Alexander. Non era possibile tornare in valle, in paese, aspettare la primavera al sicuro con un tetto sopra la testa. La cercavano, su di lei pendeva una taglia, bisognava cavarsela in qualche modo, cercare di sopravvivere in montagna, in rifugi precari, al freddo, nascosta “in assoluto adiaccio contro una roccia a quota duemila, non grotta, ma un appiombo delle Marmarole ai margini di fitte faggete”(*) con un paio di compagni, con le orecchie sempre tese: bastavano le tracce sulla neve per portare a loro.
Finisce anche l’inverno, quelli rimasti riprendono la lotta, fino a un aprile convulso e feroce, alla fine del quale non sono molti i compagni ancora vivi.
Sono pagine di una scrittura scarna e asciutta, vi è narrato poco di epico o eroico, venata da una tristezza che non cessa nemmeno con la liberazione e la fuga dell’ultima colonna di panzer:
“Non ho ucciso stamane, la guerra è finita davvero, anche da noi qui, verso mezzogiorno.
A Pieve di Cadore (come in troppi altri posti) è stata una fine amara, tra morti e macerie gratuite e assurde.
Stamane una colonna di panzer tedeschi da 88 millimetri risaliva dalla Val Piave, indomiti, feroci, sfegatati, decisi a continuare la guerra.
Inutile trattare con loro, offrire una resa, un ritorno alle loro case ormai tanto vicine, senza passare per i «lager» americani.
No, comandanti fanatici e soldati ridotti come macchine spietate non vogliono lasciare le armi, arrendersi; c’è stata battaglia in piazza a Pieve, hanno sparato coll’88 millimetri e sfondato case, hanno ucciso a raffiche Diana, il più giovane dei nostri (quindici anni) e ferito parecchi altri.
[…]
Quel panzer scassato sferraglia e va via. È l’ultimo rumore di guerra nella piazza piena di macerie, attraversata da una manica da fuoco a spegnere un inizio di incendio.
La barella di Diana come un lugubre soffio ha fatto silenzio; a lungo, e muoversi senza parlare, senza saper cosa fare, lentamente: è questa la fine, la pace?
Per quanto tempo non so, minuti, quarti d’ora; lento uscire di gente guardinga, senza parole. Una maestra elementare con una coccarda, ma è come un senso di ridicola, innocente rettorica che ti strappa quasi un sorriso, un pompiere tutto fuligginoso viene al balcone del Palazzo della Comunità e mette fuori la bandiera, lo fa senza gesti inutili, e veramente questa fa piacere vederla; uno ha detto «Légala a mezzo, ci sono dei morti».”
C’è Sergio, in un angolo, armato e tanto magro e piccolo che, se non mi fosse usuale come un fratello, non saprei se è un ragazzo o un attaccapannino di armi. Silenzioso, contratto, tutto occhi come sua madre. Ci guardiamo in silenzio, non abbiamo voglia di parlare; ci passano davanti quei tipi paludati di tricolori e coccarde, passa via la camionetta dei tommies e delle ragazze. Da sotto le armi esce la voce bassa e roca, staccata, di Sergio:
«Adesso comincia il casino, vedrai che razza di casino ci impiantano». Pensiamo ambedue a Severino che non c’è più. Dice il ragazzo, ingoiando saliva:
«Vieni a casa, dai. Vieni a mangiare, intanto».
Si va giù a passo per i vicoli, via dalla piazza, estranei, con uno stomaco che deve ingoiar qualcosa e un barlume di pensiero che domani tenterà di orientarsi «in questo casino», per continuare a fare quel che volevano i morti.”
Tai di Cadore, 2 maggio 1945
(*) da una lettera del 1962 di Giovanna Zangrandi a Vittorio Sereni


![ESC_5288[8] ESC_5288[8]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbaJSyx29nlZTzowft3zYMwU6tMlSm7ktHg1CQ_DDF4uDSxfmrX0S2wV1gNoBVGdNU8ukPJeS6eWpx6zVwXWWV5wWJa0GxrFSlb2Nt3GQgV04nuVYcFLTV2Grno0_GFWR6yhBtdezDtwY/?imgmax=800)